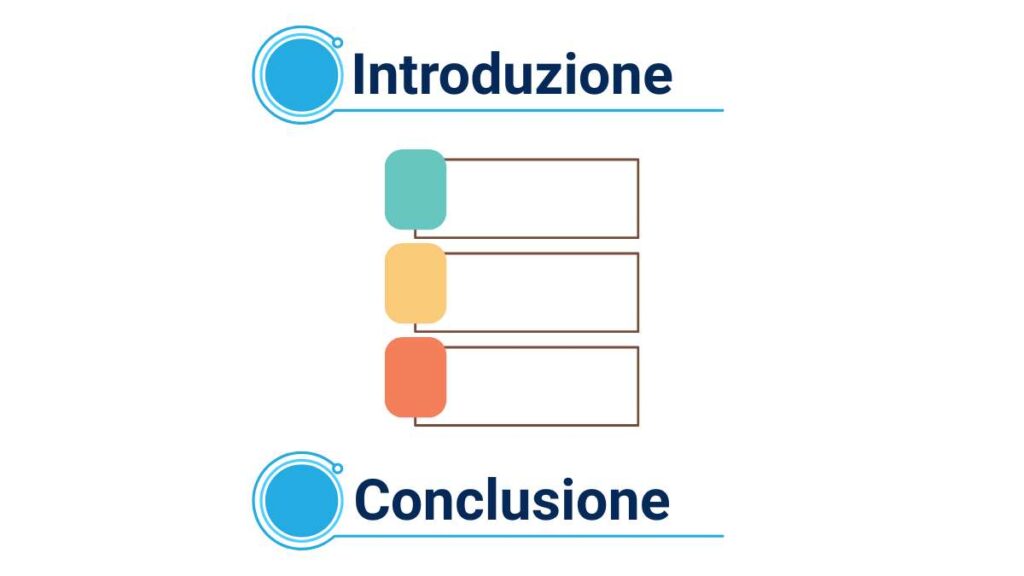La tecnica del red herring: come scrivere
Nel mondo della scrittura e della comunicazione persuasiva, pochi espedienti narrativi sono efficaci quanto il red herring, una tecnica che consiste nel depistare intenzionalmente il lettore o l’ascoltatore, guidandolo verso una falsa pista per aumentare suspense, attenzione e coinvolgimento.
Nato come stratagemma tipico dei romanzi gialli e dei thriller, il red herring è oggi ampiamente utilizzato non solo nella narrativa, ma anche nella comunicazione contemporanea, nel marketing, nei media e persino nel dibattito pubblico.
Capire come funziona questo meccanismo significa acquisire una competenza preziosa: saper dirigere l’attenzione, creare aspettative, gestire la curiosità e guidare il lettore lungo un percorso intenzionale, senza mai perdere chiarezza e coerenza.
Per chi scrive — che si tratti di storytelling, content creation, copywriting o sceneggiatura — conoscere la tecnica del red herring permette di costruire contenuti più dinamici, emotivamente coinvolgenti e memorabili.
In questo articolo analizzeremo cos’è il red herring, da dove nasce, perché è psicologicamente così efficace e come può essere applicato oggi per rendere la scrittura più sofisticata e avvincente, evitando però cadute di stile o manipolazioni non etiche.
Che cos’è la tecnica del red herring
Dopodiché erano usate per addestrare i cani alla caccia alla volpe. Esse, infatti, creavano delle false piste di odore in grado di distrarre gli animali dai percorsi principali.
- creare suspense, tensione e coinvolgimento;
- aggiungere profondità e complessità alle storie;
- approfondire i personaggi e le dinamiche della storia;
- mostrare motivazioni nascoste, debolezze o segreti.
Strategie per scrivere un red herring efficace
Come abbiamo visto finora, l’obiettivo del red herring non è ingannare senza senso, ma creare suspense, tensione e coinvolgimento e rendere la storia più complessa e stimolante.
Per farlo in modo ottimale è necessario:
- introdurre elementi ambigui: creare personaggi e dettagli che sembrano sospetti e rilevanti;
- fare in modo che comportamenti e dichiarazioni di questi possano essere interpretati in più modi;
- distribuire indizi falsi in modo che abbiano un senso all’interno della storia, per non far sentire il lettore ingannato gratuitamente;
- inserire dettagli che sembrano importanti, ma alla fine si rivelano irrilevanti;
- mantenere la narrazione credibile alternando e bilanciando red herring con indizi veri;
- sfruttare le aspettative del pubblico giocando con stereotipi e luoghi comuni: il lettore spesso interpreta gli eventi basandosi su ciò che si aspetta;
- mantenere coerenza tematica e stilistica: se la falsa pista è troppo ovvia o fuori contesto, il lettore percepisce il trucco e perde fiducia nella narrazione.
Le tipologie di red herring più utilizzate all’interno di una narrazione sono:
- personaggio sospetto: il classico presunto colpevole che distoglie l’attenzione dal vero antagonista;
- oggetto o indizio fuorviante: documenti, prove o eventi che sembrano cruciali ma invece non lo sono;
- informazione irrilevante: notizie o dettagli che distraggono dalla trama;
- dialogo ingannevole: conversazioni che suggeriscono colpe o intenzioni errate.
Dalla narrativa alla comunicazione
In questo senso, nei media, nel giornalismo e nella politica viene spesso impiegato per deviare l’attenzione da temi scomodi spostando il discorso su argomenti meno critici.
- evitare responsabilità: deviare l’attenzione da questioni critiche o delicate;
- spostare l’attenzione: far concentrare il pubblico su dettagli secondari ed apparentemente più importanti;
- controllare la narrativa: guidare la percezione pubblica e il flusso della discussione;
- influenzare l’opinione pubblica: orientare giudizi e emozioni, spesso sfruttando stimoli emotivi.
- distrazione: evidenzia come l’attenzione umana possa essere facilmente deviata introducendo elementi irrilevanti;
- agenda-setting: mostra come i media possano influenzare i temi di cui il pubblico si crea opinioni, indirizzando la percezione verso dettagli secondari. framing: spiega come la presentazione stessa delle informazioni possa guidare interpretazioni e percezioni;
- manipolazione dell’informazione: indica come modificare opinioni e comportamenti, deviare giudizi e influenzare decisioni.
Effetti psicologici e impatti sul pubblico
- introducono elementi irrilevanti che aumentano la quantità di informazioni che la mente deve elaborare;
- rendono più difficile focalizzarsi sui punti cruciali creando un sovraccarico;
- causano, di conseguenza, semplificazioni ed interpretazioni superficiali;
- sfruttano il bias di conferma, meccanismo per cui le persone tendono a cercare informazioni che confermano le proprie convinzioni, ignorando dati contrastanti;
- fanno emergere una riduzione della criticità, fenomeno che avviene quando la presenza di stimoli distrattivi porta ad aumentare la probabilità di accettare interpretazioni semplicistiche.
- indirizzando l’attenzione verso elementi che rafforzano pregiudizi esistenti.
- sovraccarico informativo: la mente deve gestire dettagli irrilevanti, complicando la comprensione;
- perdita di concentrazione: l’attenzione si disperde su elementi secondari, riducendo la capacità di valutare correttamente l’informazione principale;
- rafforzamento dei pregiudizi: il pubblico tende a confermare opinioni preesistenti, ignorando segnali contrari;
- riduzione della fiducia: una volta identificata la manipolazione, nasce un senso di sospetto e scetticismo verso chi comunica.
Esempi celebri di red herring in narrativa, cinema e serie TV
Il red herring è una tecnica narrativa che ha segnato alcuni dei più grandi capolavori del giallo e del thriller. Analizzare esempi reali aiuta a capire come funziona in pratica questo meccanismo di depistaggio e perché risulta così efficace nel catturare l’attenzione del pubblico.
1. Sherlock Holmes: l’arte del depistaggio secondo Arthur Conan Doyle
Nelle storie di Sherlock Holmes, Conan Doyle utilizza spesso personaggi dall’apparenza sospetta — vicini alla vittima, burberi, poco collaborativi — che sembrano avere tutte le caratteristiche dell’assassino.
Solo nelle pagine finali si scopre che la figura apparentemente innocua, spesso ignorata, era invece il vero colpevole.
Perché funziona?
Perché sfrutta i pregiudizi del lettore, che tende a diffidare di chi appare ambiguo. Il red herring ribalta queste aspettative.
2. Agatha Christie e le false piste ne “L’Orient Express”
In Assassinio sull’Orient Express, Agatha Christie moltiplica deliberatamente indizi contraddittori, ognuno dei quali sembra puntare verso un colpevole diverso.
In realtà, ogni indizio è progettato per distogliere l’attenzione dalla verità finale.
Perché funziona?
Perché Christie inserisce troppe informazioni, creando un equilibrio sottile tra verità e depistaggio. Il lettore sente di avere tutto sotto controllo… finché la soluzione non lo sorprende.
3. “Psycho” di Hitchcock: il capolavoro del cinema del depistaggio
Il film Psycho (1960) è uno dei massimi esempi di red herring nel cinema.
Hitchcock induce lo spettatore a credere che l’antagonista sia la madre di Norman Bates, attraverso ombre, voci e movimenti dietro la tenda.
Alla fine, la rivelazione mostra che la madre è morta da anni e che è Norman a impersonarla.
Perché funziona?
Hitchcock gioca con informazioni visive e sonore ingannevoli, dimostrando quanto il red herring sia potente nelle arti visive.
4. Harry Potter: Piton come falso sospetto ricorrente
Nei romanzi di J.K. Rowling, Severus Piton viene costruito come un sospetto ideale: oscuro, ambiguo, ostile, pieno di segreti. Per anni il lettore è convinto che sia lui a tramare alle spalle di Harry.
Alla fine si scopre invece che Piton è uno dei personaggi più leali della saga.
Questo è uno dei red herring più riusciti nella letteratura young adult moderna.
5. “Seven” di David Fincher: l’assassino fuori campo
Nella prima parte del film Seven, lo spettatore viene indotto a seguire una serie di indizi che sembrano condurre a sospettati periferici.
In realtà, il serial killer — interpretato da Kevin Spacey — non appare quasi mai fino alla metà del film, mantenendo l’attenzione su bersagli sbagliati.
Perché funziona?
Perché la mancanza di informazioni è essa stessa un depistaggio: si dà per scontato che il killer debba “apparire”, ma non succede.
6. “The Usual Suspects”: Keyser Söze e la falsa identità
Nel film I soliti sospetti, l’intera indagine ruota attorno all’identità di Keyser Söze.
Il personaggio Verbal Kint sembra il più innocuo del gruppo… fino al colpo di scena finale.
Perché funziona?
Il film usa narrazione inaffidabile, una tecnica potente di red herring che distorce la percezione dello spettatore.
7. La serie “Stranger Things”: gli adulti come falsi antagonisti
Nella prima stagione, il governo americano e il laboratorio sembrano responsabili diretti dei fenomeni sovrannaturali. In realtà, le creature del Sottosopra e gli esperimenti collaterali sono la causa scatenante.
Perché funziona?
Perché sfrutta la naturale sfiducia dello spettatore verso le istituzioni, mettendo in campo un pregiudizio narrativo facile da attivare.
Vedendo il red herring all’opera nei grandi capolavori, emergono tre principi fondamentali:
- Il depistaggio deve essere credibile, non campato in aria.
- Non deve tradire il patto narrativo con il lettore: sorpresa sì, inganno gratuito no.
- Funziona quando sfrutta bias cognitivi: pregiudizi, aspettative, schemi mentali.
Applicati correttamente, questi elementi permettono di creare suspense, ritmo e partecipazione emotiva.
Applicazioni del red herring nel marketing e nella comunicazione persuasiva
Sebbene il red herring nasca come tecnica narrativa per creare suspense e depistare il lettore, i suoi principi si applicano sorprendentemente bene anche al mondo del marketing, della pubblicità e della comunicazione persuasiva.
Non si tratta — è bene chiarirlo — di ingannare il pubblico, ma di guidarne l’attenzione, lavorando sulle aspettative e sui bias cognitivi che orientano le decisioni.
In un’epoca dominata dall’iperstimolazione e dalla saturazione dei contenuti, attirare e trattenere lo sguardo è una sfida sempre più complessa. Il red herring, se utilizzato in modo etico e strategico, può diventare uno strumento utile per creare sorpresa, rompere lo schema e rendere memorabile un messaggio.
Spostare l’attenzione per creare curiosità
Una delle applicazioni più diffuse del red herring in comunicazione consiste nel dirigere volontariamente l’attenzione del pubblico verso un elemento secondario, per poi ribaltarla con un’informazione chiave.
È una dinamica molto comune negli spot video, dove la narrazione procede in una direzione “apparente”, fino al twist finale che rivela il messaggio reale.
Esempio classico: uno spot che sembra raccontare una storia d’amore o di famiglia…finché non si scopre che si tratta di una campagna per la sicurezza stradale o contro le distrazioni al volante.
Il depistaggio iniziale crea un coinvolgimento emotivo, mentre la rivelazione finale imprime il messaggio con maggiore forza.
Rompere le aspettative per aumentare l’impatto del brand
Il cervello umano è programmato per prevedere e categorizzare ciò che guarda. Quando qualcosa rompe quella previsione, l’attenzione si riaccende.
Il red herring sfrutta proprio questa dinamica: creare aspettativa -> deviazione -> sorpresa.
Molti brand lo utilizzano per:
- lanciare campagne “a tema” che sembrano parlare di una cosa ma in realtà preparano il lancio di un prodotto diverso;
- creare teaser ambigui, che aprono conversazioni e stimolano il passaparola;
- costruire storytelling dove il pubblico pensa di conoscere l’esito… finché non arriva il twist.
Il risultato?
Un messaggio più memorabile, perché si distingue dalla routine comunicativa.
Usare il depistaggio per sottolineare un valore o un problema
Alcune campagne sociali usano il red herring per amplificare l’impatto emotivo.
Fanno credere allo spettatore di trovarsi di fronte a una situazione quotidiana, leggera o divertente, per poi rivelare:
- dati scioccanti,
- un problema ignorato,
- una verità scomoda.
Questo meccanismo — sorpresa controllata — funziona perché porta lo spettatore a ripensare le proprie convinzioni, senza sentirsi “istruito dall’alto”.
Nelle landing page: guidare lo sguardo, senza ingannare
Nelle pagine web il red herring assume un significato diverso, più sottile e più vicino al neuromarketing: non si tratta di raccontare una storia falsa, ma di organizzare gli elementi visivi per guidare il flusso di attenzione.
Esempi tipici:
- inserire un elemento visivamente dominante (immagine, titolo, mockup) che “prende” lo sguardo, mentre la CTA compare subito dopo in un punto strategico;
- creare micro-narrazioni che sembrano condurre a un beneficio, per poi rivelare quello realmente rilevante;
- usare intestazioni e micro-copy che sembrano aprire una direzione (“Vuoi spendere meno?”) per poi offrire la soluzione vera (“In realtà vuoi ottenere di più con lo stesso budget”).
Non si mente: si orchestra il percorso di lettura.
Nel branding: ribaltare identità e percezioni
Alcuni brand giocano con il red herring a livello identitario:
- si presentano come “tradizionali” e poi sorprendono con un prodotto innovativo;
- si mostrano “ribelli” per poi rivelare una mission etica;
- si fanno percepire come “di lusso” per poi proporre accessibilità.
È un modo per costruire una narrazione dinamica, che sfida preconcetti e obbliga il pubblico a ripensare al significato del brand.